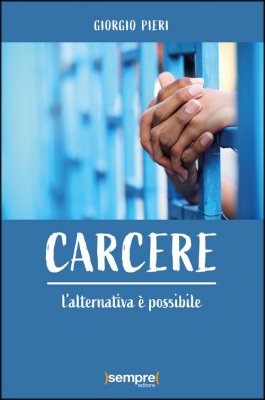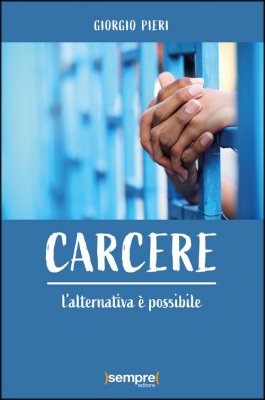Il nostro legale, esperto di diritti umani, ci spiega come è nata questa norma, quali misure prevede, nei confronti di chi viene applicata, e propone alcuni criteri per valutare la sua compatibilità con i principi costituzionali.
L’8 giugno 1992, poco più di due settimane dopo l’attentato di Capaci del 23 maggio, venne approvata la legge Martelli-Scotti che introdusse una novità sostanziale: il regime carcerario previsto dall’art. 41-bis o.p. (Legge sull'ordinamento penitenziario n.354/75) il c.d.
“carcere duro” (utilizzato prima di allora solo in casi eccezionali di rivolte in carcere) poteva essere applicato anche verso detenuti appartenenti alla mafia.
In pratica, da quel momento potevano essere sottoposti al 41-bis anche i detenuti
per reati di mafia i quali, in virtù dei legami con le associazioni criminali di appartenenza, erano in grado di continuare a delinquere anche dal carcere, neutralizzando così la loro pericolosità.
Carcere: l'alternativa � possibile
Il libro di Giorgio Pieri
Per questi, si poteva sospendere la messa in pratica delle regole ordinarie di trattamento dei carcerati nell'istituto penitenziario, salvo decidessero di collaborare con la Giustizia.
L’istituto subì in seguito molti aggiustamenti di normativa e solo nel 2009 prese la forma che ha oggi.
Cosa prevede il 41-bis
Il 41-bis è un regime penitenziario differenziato e speciale.
Può essere applicato ai detenuti
per quattro anni con possibilità di proroghe «quando risulta che la capacità [del detenuto] di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno».
Ecco cosa prevede:
-
Il detenuto sottoposto alle restrizioni deve essere isolato dagli altri, dormire in una cella singola e non può accedere agli spazi comuni.
-
La cosiddetta “ora d’aria”, il momento in cui il carcerato può uscire dalla cella e andare nel cortile, è più limitata.
-
Possono essere ristretti anche i colloqui coi familiari, rigidità attenuata in presenza di figli o nipoti infra-dodicenni.
-
Le telefonate sono registrate, i colloqui ripresi da una telecamera, la posta del detenuto viene controllata sia in entrata sia in uscita.
-
Ci sono limitazioni al denaro che può tenere sul suo conto in carcere, e, degli oggetti in cella, libri e giornali sono banditi.
-
La sorveglianza è attribuita ad un reparto speciale di polizia che non entra in contatto con gli altri poliziotti penitenziari.
A chi si applica il 41-bis
L’applicazione dell’istituto può riguardare anche reati non di tipo mafioso ma estremamente gravi come:
-
delitti di terrorismo,
-
reati di pedopornografia,
-
tratta di essere umani,
-
violenza sessuale di gruppo,
-
sequestro di persona,
-
traffico di stupefacenti.
Chi sono i detenuti in carcere con il 41-bis
Nel novembre 2021 i detenuti al 41-bis erano
749 di cui 13 donne (Fonte:
rapporto Antigone)
Quanto all’appartenenza alle organizzazioni criminali, secondo la disponibilità di dati più specifici risalenti al 2019,
gli affiliati alla camorra erano 255, alla ‘ndrangheta 201, alla mafia siciliana 213.
Al 41-bis, nel 2021, c’erano anche
41 appartenenti alla cosiddetta quarta mafia, cioè la criminalità organizzata pugliese;
29 erano affiliati ad altre forme di criminalità siciliane;
tre a organizzazioni lucane. (
Fonte: Flourish)
Inoltre era previsto per
tre detenuti per delitti di terrorismo e
tre persone in carcere per altri reati.
La Corte europea: compatibile, ma a certe condizioni
L’applicazione del c.d. “carcere duro” ha un equilibrio molto instabile in quanto comprime severamente il godimento dei diritti fondamentali dell’individuo. Una forte compressione delle libertà e delle esigenze primarie, che non sia equamente bilanciata al pericolo sociale e ad esigenze di ordine pubblico può facilmente cadere nella logica esclusivamente repressiva, contraria alla Costituzione e alla funzione rieducativa della pena. Il passo tra un carcere impermeabile e abusi consumati nei confronti dei detenuti con un sacrificio ingiustificato dei principi costituzionali, può essere anche molto breve.
Carcere: l'alternativa � possibile
Il libro di Giorgio Pieri
A livello nazionale la valutazione di compatibilità del 41 bis con gli standard di tutela dei diritti umani è stata
più volte oggetto di esame da parte della magistratura e numerose sono state le iniziative della società civile per una revisione della normativa.
Anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa. Pur non essendo uscito sempre intonso dal vaglio di Strasburgo, per diverse “condanne” al governo italiano,
il 41 bis è stato sino ad ora ritenuto compatibile con l’art. 3 CEDU
(divieto di tortura e i trattamenti disumani e degradanti), in considerazione, da un lato, del
carattere temporaneo dell’isolamento cui sono sottoposti i detenuti e, dall’altro, delle
rilevanti esigenze di prevenzione che esso persegue.
Sia i Tribunali italiani che quelli europei, se da un lato hanno riaffermato il solenne del principio per cui la compressione dei diritti fondamentali della persona deve
rispondere a rigorosi criteri di necessità e di proporzione e non può mai tradursi in limitazioni tali da violare la dignità della persona umana
, dall’altro hanno fissato come
valore imprescindibile e baricentrico il bilanciamento degli interessi in gioco, in concreto e sul singolo caso.
Il regime carcerario del 41 bis è giustificabile quando la sicurezza e l’interesse pubblico abbiano un grado di intensità tale da prevalere sull’interesse dell’individuo ma solo trovando come confini invalicabili di riferimento gli artt. 13 (atto motivato dell'Autorità Giudiziaria e possibilità di ricorso), 27 (finalità rieducativa della pena e divieto trattamenti disumani) e 32 (diritto alla salute) della Costituzione.
Se quindi non si possono disconoscere le serissime esigenze di prevenzione speciale che stanno alla base del regime detentivo speciale del “carcere duro”, d’altra parte il forte carico afflittivo - spesso di una durata indeterminata - e la valutazione dei numerosi i correttivi giurisprudenziali apportati, rendono ragionevole approfondire anche eventuali vie di rifondazione di questa misura di sicurezza in modo che
mantenga il suo fine preventivo, senza automatismi o generalizzazioni, e si traduca in modulazioni trattamentali idonee ad impedirne gli eccessi di scopo.